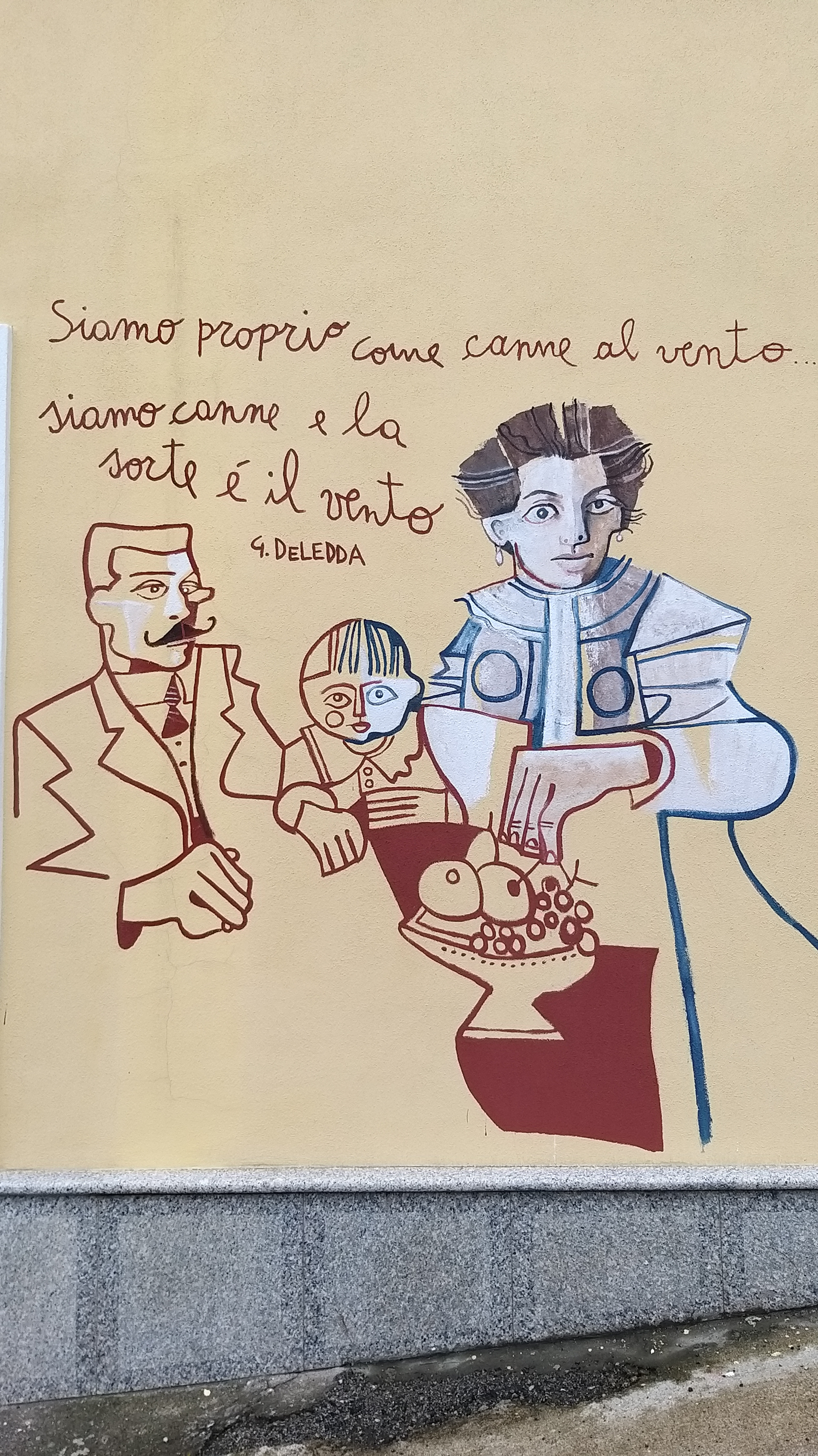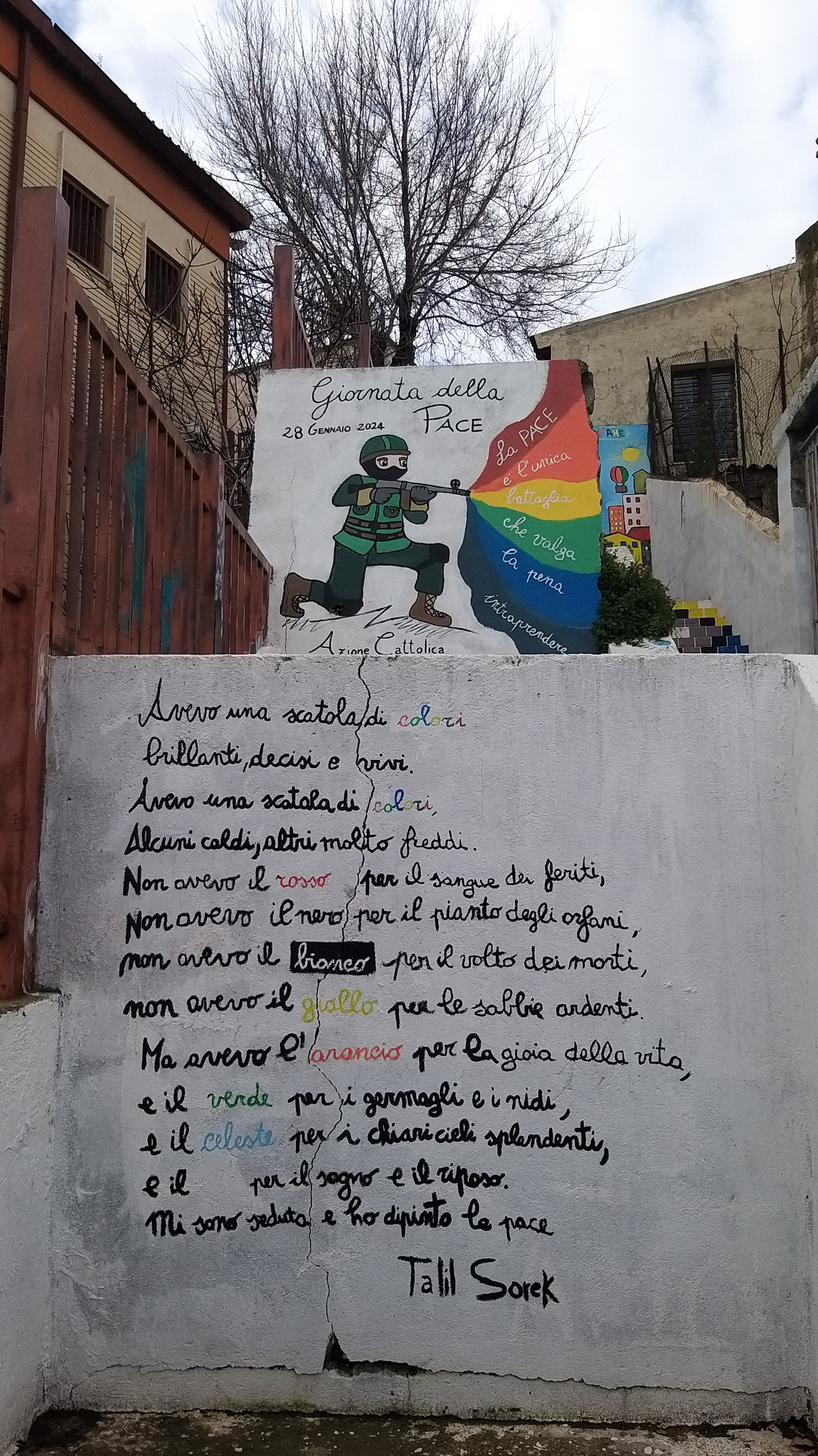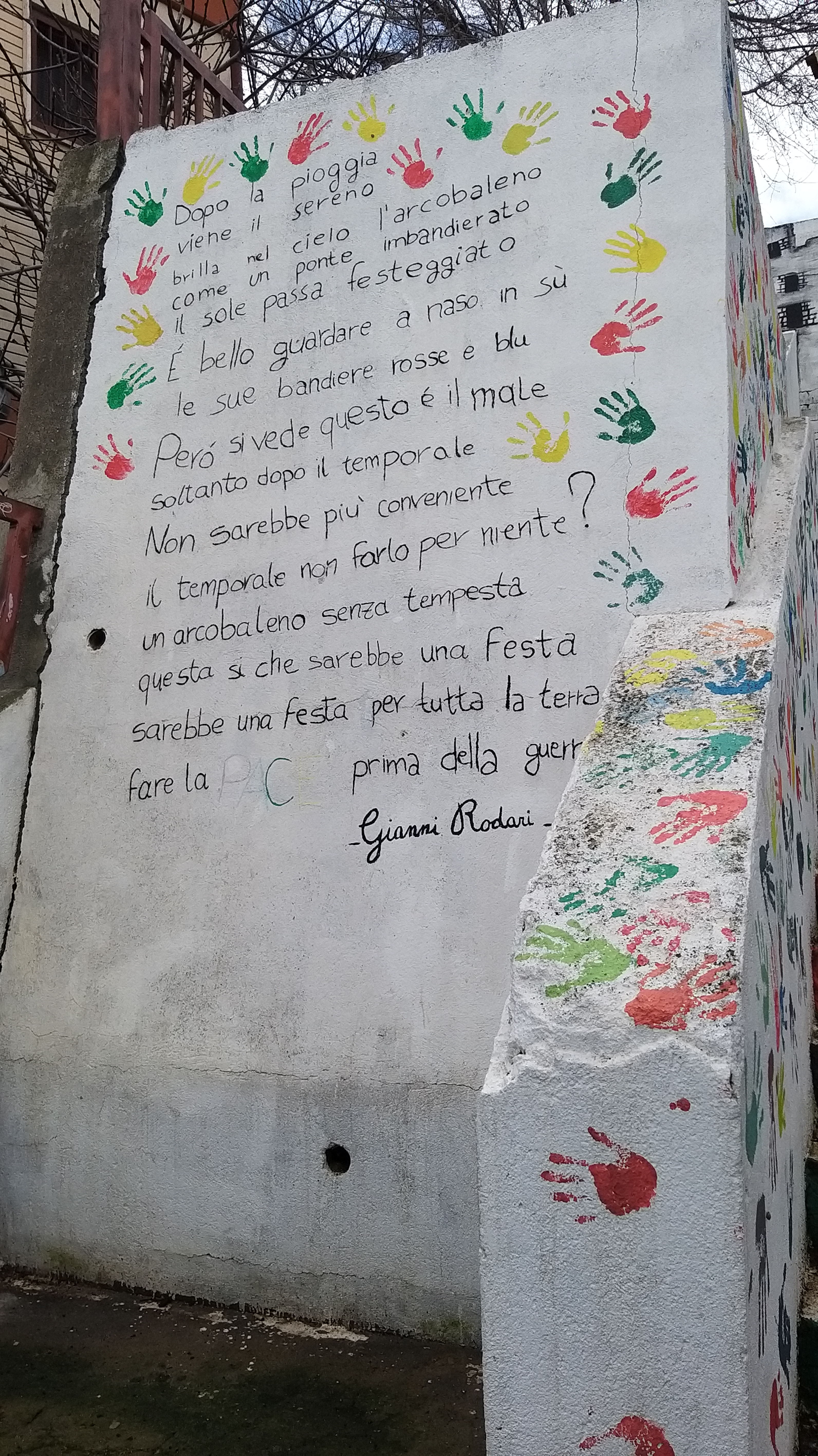A gennaio, in occasione di Sant’Antonio, iniziano ad accendersi i fuochi del Carnevale in Sardegna. Intorno al fuoco prendono vita riti ancestrali, appartenenti a un mondo antico non del tutto scomparso, legato ai cicli naturali e agricoli.
Non sono esattamente una fanatica del Carnevale, inteso come festa dove gli eccessi e il ribaltamento dell’ordine sociale prendono simbolicamente forma a suon di travestimenti e musiche festose. Ma in qualità di antropologa di formazione, sono attratta dagli antichi riti di passaggio in cui l’uomo celebra il suo legame con la terra.
Dove, se non in Sardegna, isola che mantiene ancora viva la sua anima agropastorale, si può respirare ancora l’autenticità di queste celebrazioni, tramandate per secoli e secoli?



A ognuno il suo Carnevale.
In Sardegna ogni località ha il suo Carnevale e in Barbagia c’è forse la sua massima espressione.
A Mamoiada troviamo Mamuthones e Issohadores, di cui parlerò tra poco. A Ottana ci sono maschere dalle lunghe corna, i Boes e i Merdules. A Orotelli i Thurpos (i ciechi), vanno in scena incappucciati e con i volti ricoperti di fuliggine. A Fonni troviamo la maschera de s’Urzu (orco o orso), una testa di caprone con lunghe corna e un fazzoletto nero da donna in testa.
Seppure i rituali e le maschere abbiano caratteristiche diverse, il comune denominatore è il rapporto tra uomo e animale, tra padrone e servi, nonché la celebrazione del ciclo della vita, tra morte e rinascita.
Per anni ho sognato di esplorare l’entroterra sardo e immergermi nelle sue antiche tradizioni; la figura del Mamuthone ha sempre suscitato in me forte suggestione. Così un giorno sono partita e, sebbene avessi pochi giorni a disposizione, ho raggiunto il cuore pulsante della Barbagia per assistere al famoso Carnevale di Mamoiada.
Il Carnevale di Mamoiada.
A Mamoiada i protagonisti del carnevale sono i Mamuthones, uomini vestiti di pelli di pecora nera, con il viso coperto da maschere di legno dall’espressione sofferente (sa visera). In testa hanno avvolto un fazzoletto, che richiama il femminile. Sulla schiena, sa càrriga, il grappolo di campanacci e sonagli con un peso che può raggiungere i 25 kg.
Durante la processione (perché più che una sfilata sembra una processione), i Mamuthones procedono in silenzio, con le espressioni cupe delle loro maschere, in una danza fatta di movimenti delle spalle e pesanti saltelli grazie ai quali i campanacci risuonano. E’ una coreografia semplice, ma rigorosa e ipnotica, che non ha niente a che vedere con le comuni danze carnevalesche piene di goliardia.
Forse la cosa che più mi ha colpita è stato proprio questo: l’assenza di musiche, il silenzio interrotto solo dal suono metallico dei campanacci, che dona alla manifestazione un’aurea di sacralità e mistero.
Insieme ai Mamuthones, sfilano gli Issohadores, che indossano invece un corpetto rosso e una maschera bianca; in mano tengono la soha, un laccio che usano per catturare simbolicamente le persone, e sono disposti nella sfilata in modo apparentemente meno ordinato.




La danza messa in scena a Mamoiada ha origini antiche e misteriose ed è stata interpretata in diversi modi.
Qualcuno ritiene si tratti della riproduzione di antichi riti propiziatori, per rendere omaggio alla natura dalla quale la vita dell’uomo dipende visceralmente. Qualcuno ha visto nelle maschere scure simboli demoniaci.
Altri riconoscono la celebrazione del ciclo di morte e rinascita rappresentato dal susseguirsi delle stagioni, al quale sono legate anche le fasi produttive del lavoro nei campi e con le bestie; le maschere animalesche raffigurerebbero gli animali allevati, mentre gli Issohadores sarebbero i pastori che li governano. L’espressione sofferente delle maschere dei Mamuthones richiama alla fatica e al sacrificio del lavoro agricolo, come d’altronde il peso dei massicci campanacci che portano sulla schiena.
Saltando, inoltre, è come se calpestassero pesantemente la terra, quasi a voler causare un risveglio della natura che diventa nuovamente viva e produttiva dopo l’inverno.
Dall’altro lato, gli Issohadores hanno un ruolo più giocoso all’interno della sfilata; spezzano il cupo rigore dei Mamuthones entrando in contatto con il pubblico, come se uscissero dalla dimensione sacra per entrare nel profano.
Lanciando la corda e tentando di catturare gli spettatori, compiono un gesto di buon augurio, un segno di prosperità e fertilità futura.
Non solo Mamuthones.
Mamoiada è conosciuta per lo più per il Carnevale, intorno al quale si sviluppa la maggior parte della sua offerta culturale. Il piccolo borgo ospita infatti il Museo delle maschere mediterranee e si possono trovare botteghe artigiane che riproducono i famosi travestimenti. Tutt’intorno, c’è la maestosa terra di Barbagia, con boschi, vigneti e sentieri di pastori, all’ombra del Supramonte e il Gennargentu.
Importante è anche la presenza di monumenti preistorici nei dintorni di Mamoiada: ci sono dolmen del Neolitico, pedras fittas (menhir), domus de Janas e nuraghi.




Poco fuori dal centro cittadino si trova sa Perda Pintà (la pietra dipinta), nota anche come stele di Boeli: è una lastra granitica alta oltre due metri e mezzo, adornata con cerchi concentrici, bastoni uncinati e coppelle, simboli legati a culto della fertilità e al concetto di morte e rinascita.
Le tracce dell’uomo del passato resistono quindi, in Barbagia, sotto forma di granitica pietra ma anche come performance culturale, come appunto nel caso del Carnevale.
Pensati Mamuthone.
Non solo il passato permane, ma è più vivo e sentito che mai, ancora oggi. Per celebrare il Carnevale nulla è lasciato al caso; i Mamuthones non sono persone qualunque, ma membri della comunità, scelti dalla comunità, e spesso appartengono a famiglie di pastori che si tramandano questo ruolo generazione dopo generazione.
Il momento della vestizione e della prima uscita dei Mamuthones e Issohadores (che avviene appunto il 17 gennaio a San’Antonio) è un momento importante, quasi sacro. Sembra un vero e proprio rito di passaggio in cui l’uomo smette di essere uomo, si trasforma e diventa maschera. E la maschera, il Mamuthone, è custode delle radici di un popolo.
Durante le celebrazioni di Mamoiada del 2025, c’era una ragazza che indossava il vestito da Mamuthone con un cartello attaccato alla schiena che diceva “Pensati Mamutone”, riprendendo il trend lanciato qualche anno fa da Chiara Ferragni con il suo “Pensati Libera”.
Sul momento mi ha fatto sorridere, ma poi ripensandoci, essendo tale maschera simbolo di trasmissione culturale, non posso che interpretare questo messaggio come un segno di buon auspicio per il popolo sardo. Siate fedeli alla vostra storia, custodi della vostra cultura e difensori della vostra terra.
Pensatevi Mamuthones.
Ringrazio Giulio che mi ha assecondata in questo folle viaggio nel cuore di Barbagia.
SE I MIEI ARTICOLI TI PIACCIONO… Segui la mia pagina FB per essere sempre aggiornato sui nuovi articoli e iscriviti gratuitamente a WordPress! Per vedere le foto più belle dei miei viaggi, segui i profili Instagram: perdersi_traveldiary e montagna_schiappa